 |
| Sanremo (IM): uno scorcio di Piazza Eroi Sanremesi, ripreso più o meno all'altezza del negozio citato in questo racconto |
Cantico di Natale anni '50 a Sanremo.
L'aria è molto fredda, il cielo è grigio e distante. La porta della nostra drogheria è semichiusa per attutire il gelo che viene dalla piazza [n.d.r.: Piazza Eroi Sanremesi di Sanremo]. La vigilia di Natale è arrivata, ma c'è un po' di tristezza nell'aria. Gli affari non vanno per niente bene perché di soldi ne circolano pochi.
Nostra mamma, come in tutte le feste, ha fatto una bella vetrina, con carta argentata, ciotole di canditi, uva sultanina, scatole di cacao, di the, di caffè. Per noi bambini questo è l'autentico segnale del Natale che sta arrivando, insieme alle vacanze scolastiche che sono già iniziate da un giorno. Ci divertiamo a stare in negozio come i grandi e a vedere entrare ed uscire le persone. E' bello anche guardare fuori: dal mattino presto si sono installati in piazza con un banco provvisorio, sicuramente abusivo, fatto di due cavalletti e un asse abbastanza lungo, due o tre individui che da noi si chiamano "lingere". Sono giovanotti, ma nemmeno tanto giovani, mal messi e con una fama da "faignants", da fannulloni. Quello di loro che viene abitualmente chiamato "Rovinafigli", in memoria di un'epica lite da lui sostenuta contro alcuni suoi stretti famigliari, è a capo dell'impresa. Hanno costruito con cartoni e colla delle capanne un po' storte che probabilmente non vedranno mai nascere il Bambino. Speravano di fare un po' di soldi, ma in tutta la giornata non sono riusciti a vendere niente. Si fa scuro e il freddo si sente di più. Entra da noi in negozio, per riscaldarsi, Gambin (così è chiamato da tutti nella piazza ma non sappiamo il perché). Possiede un baracchino (lui lo chiama azienda) dirimpetto al nostro negozio. Vende ostriche ed altri frutti di mare e normalmente si tira su, inverno ed estate, bevendo "cicchetti" uno dopo l'altro, reggendo straordinariamente bene tutti i generi di alcolici. Mia mamma, che si immedesima nel fallimento dei venditori di capanne ("non sono nemmeno al coperto e si prendono tutto il freddo di questa Vigilia gelida") esprime la sua pena per loro: vorrebbe avere tanti soldi per comprargliele lei tutte quelle capanne. Gambin sostiene invece che non darebbe nemmeno un soldo a degli scansafatiche poco di buono che dovrebbero solo andare a lavorare. Si rompe inevitabilmente l'atmosfera di comprensione universale e siamo riportati tutti sulla spietata terra.
Ormai è venuta l'ora di chiusura, i negozi stanno tirando giù le saracinesche, anche Gambin è andato a chiudere la sua azienda. Nella quiete un po' sorda della sera natalizia sentiamo delle urla nella piazza. Finalmente qualcosa di interessante da vedere, anche per noi bambini: Rovinafigli, ormai in preda ad una rabbia violenta e ai tanti bicchieri bevuti per scaldarsi, sta scagliando a terra, una per una, le capanne invendute, praticamente tutte. Bestemmie volano insieme ai sacri manufatti, qualche passante si ferma incuriosito, tutti noi, grandi e piccini, assistiamo senza fiatare alla fine violenta di grandi speranze. L'ostricaio è l'unico che tenta di opporsi a quella tempesta distruttiva.
"Ma dai, non fa cuscì! Ti purerai vendile l'annu proscimu" (Ma dai, non fare così! Potrai venderle l'anno prossimo) e intanto afferra una capanna. "Ti vei, ‘sta chi a l'è bèla, tegnila!"(Vedi, questa è bella, tienila!). Ma Rovinafigli è ormai al di là di ogni ragione. "Na, a veuio buttà tutto. A sun disgrasiau. Maledete ste feste e chelu che u l'ha inventae!" (No, voglio buttare tutto. Sono disgraziato. Maledette queste feste e quello che le ha inventate!). Gambin, con aria quasi paterna e un po' falsa, prende in mano un'altra capanna: "Sta chi damela, ciutostu che butala, cuscì duman a fassu u presepe a ca mea. In fundu i nun sun cuscì brute" (Questa dammela, piuttosto che buttarla, così domani faccio il Presepe a casa mia. In fondo non sono così brutte).
Di fronte alla valutazione decisamente modesta del suo lavoro, l'ira sale ancor di più: "Na, a devu buttà tutu, lascime sta, a sun nasciu disgrasiau! Ti u dixi anche tu che i sun brute"(No, devo buttare tutto, lasciami stare, sono nato disgraziato. Lo dici anche te che sono brutte). La rabbia e la violenza sono contagiose: finalmente anche l'ostricaio esprime il suo vero e più profondo parere e al diavolo l'amore per il prossimo. Tenendo la capanna in mano, quella che non era poi così brutta, esclama inesorabilmente il suo giudizio: "Sci, ti l'hai raixiun. I sun brute. Adessu a posciu ditelu che i sun propiu di brutesci! Aspeita ca te do ina man!" (Sì', hai ragione. Sono brutte. Adesso posso dirtelo che sono dei brutessi (cose disgustose). Aspetta che ti do' una mano!) e giù a buttare capanne per terra e a saltarci addosso con i piedi. Davanti a tutto quel furore, un po' di gente si è radunata e guarda divertita. Nessuno tenta di fermare i due invasati, qualcuno dice che è sacrilegio distruggere in quel modo delle cose destinate al Bambino. Mentre il gruppetto di curiosi si scioglie, si sente un commento anonimo ad alta voce:" Però i l'eira propiu brute! U l'è staitu meju sciapale" (Però erano proprio brutte! E' stato meglio spaccarle).
Donatella D'Imporzano
Chiara Salvini, Donatella D'Imporzano - Cantico di Natale a Sanremo anni Cinquanta, Nel delirio non ero mai sola, 25 dicembre 2024
L'aria è molto fredda, il cielo è grigio e distante. La porta della nostra drogheria è semichiusa per attutire il gelo che viene dalla piazza [n.d.r.: Piazza Eroi Sanremesi di Sanremo]. La vigilia di Natale è arrivata, ma c'è un po' di tristezza nell'aria. Gli affari non vanno per niente bene perché di soldi ne circolano pochi.
Nostra mamma, come in tutte le feste, ha fatto una bella vetrina, con carta argentata, ciotole di canditi, uva sultanina, scatole di cacao, di the, di caffè. Per noi bambini questo è l'autentico segnale del Natale che sta arrivando, insieme alle vacanze scolastiche che sono già iniziate da un giorno. Ci divertiamo a stare in negozio come i grandi e a vedere entrare ed uscire le persone. E' bello anche guardare fuori: dal mattino presto si sono installati in piazza con un banco provvisorio, sicuramente abusivo, fatto di due cavalletti e un asse abbastanza lungo, due o tre individui che da noi si chiamano "lingere". Sono giovanotti, ma nemmeno tanto giovani, mal messi e con una fama da "faignants", da fannulloni. Quello di loro che viene abitualmente chiamato "Rovinafigli", in memoria di un'epica lite da lui sostenuta contro alcuni suoi stretti famigliari, è a capo dell'impresa. Hanno costruito con cartoni e colla delle capanne un po' storte che probabilmente non vedranno mai nascere il Bambino. Speravano di fare un po' di soldi, ma in tutta la giornata non sono riusciti a vendere niente. Si fa scuro e il freddo si sente di più. Entra da noi in negozio, per riscaldarsi, Gambin (così è chiamato da tutti nella piazza ma non sappiamo il perché). Possiede un baracchino (lui lo chiama azienda) dirimpetto al nostro negozio. Vende ostriche ed altri frutti di mare e normalmente si tira su, inverno ed estate, bevendo "cicchetti" uno dopo l'altro, reggendo straordinariamente bene tutti i generi di alcolici. Mia mamma, che si immedesima nel fallimento dei venditori di capanne ("non sono nemmeno al coperto e si prendono tutto il freddo di questa Vigilia gelida") esprime la sua pena per loro: vorrebbe avere tanti soldi per comprargliele lei tutte quelle capanne. Gambin sostiene invece che non darebbe nemmeno un soldo a degli scansafatiche poco di buono che dovrebbero solo andare a lavorare. Si rompe inevitabilmente l'atmosfera di comprensione universale e siamo riportati tutti sulla spietata terra.
Ormai è venuta l'ora di chiusura, i negozi stanno tirando giù le saracinesche, anche Gambin è andato a chiudere la sua azienda. Nella quiete un po' sorda della sera natalizia sentiamo delle urla nella piazza. Finalmente qualcosa di interessante da vedere, anche per noi bambini: Rovinafigli, ormai in preda ad una rabbia violenta e ai tanti bicchieri bevuti per scaldarsi, sta scagliando a terra, una per una, le capanne invendute, praticamente tutte. Bestemmie volano insieme ai sacri manufatti, qualche passante si ferma incuriosito, tutti noi, grandi e piccini, assistiamo senza fiatare alla fine violenta di grandi speranze. L'ostricaio è l'unico che tenta di opporsi a quella tempesta distruttiva.
"Ma dai, non fa cuscì! Ti purerai vendile l'annu proscimu" (Ma dai, non fare così! Potrai venderle l'anno prossimo) e intanto afferra una capanna. "Ti vei, ‘sta chi a l'è bèla, tegnila!"(Vedi, questa è bella, tienila!). Ma Rovinafigli è ormai al di là di ogni ragione. "Na, a veuio buttà tutto. A sun disgrasiau. Maledete ste feste e chelu che u l'ha inventae!" (No, voglio buttare tutto. Sono disgraziato. Maledette queste feste e quello che le ha inventate!). Gambin, con aria quasi paterna e un po' falsa, prende in mano un'altra capanna: "Sta chi damela, ciutostu che butala, cuscì duman a fassu u presepe a ca mea. In fundu i nun sun cuscì brute" (Questa dammela, piuttosto che buttarla, così domani faccio il Presepe a casa mia. In fondo non sono così brutte).
Di fronte alla valutazione decisamente modesta del suo lavoro, l'ira sale ancor di più: "Na, a devu buttà tutu, lascime sta, a sun nasciu disgrasiau! Ti u dixi anche tu che i sun brute"(No, devo buttare tutto, lasciami stare, sono nato disgraziato. Lo dici anche te che sono brutte). La rabbia e la violenza sono contagiose: finalmente anche l'ostricaio esprime il suo vero e più profondo parere e al diavolo l'amore per il prossimo. Tenendo la capanna in mano, quella che non era poi così brutta, esclama inesorabilmente il suo giudizio: "Sci, ti l'hai raixiun. I sun brute. Adessu a posciu ditelu che i sun propiu di brutesci! Aspeita ca te do ina man!" (Sì', hai ragione. Sono brutte. Adesso posso dirtelo che sono dei brutessi (cose disgustose). Aspetta che ti do' una mano!) e giù a buttare capanne per terra e a saltarci addosso con i piedi. Davanti a tutto quel furore, un po' di gente si è radunata e guarda divertita. Nessuno tenta di fermare i due invasati, qualcuno dice che è sacrilegio distruggere in quel modo delle cose destinate al Bambino. Mentre il gruppetto di curiosi si scioglie, si sente un commento anonimo ad alta voce:" Però i l'eira propiu brute! U l'è staitu meju sciapale" (Però erano proprio brutte! E' stato meglio spaccarle).
Donatella D'Imporzano
Chiara Salvini, Donatella D'Imporzano - Cantico di Natale a Sanremo anni Cinquanta, Nel delirio non ero mai sola, 25 dicembre 2024






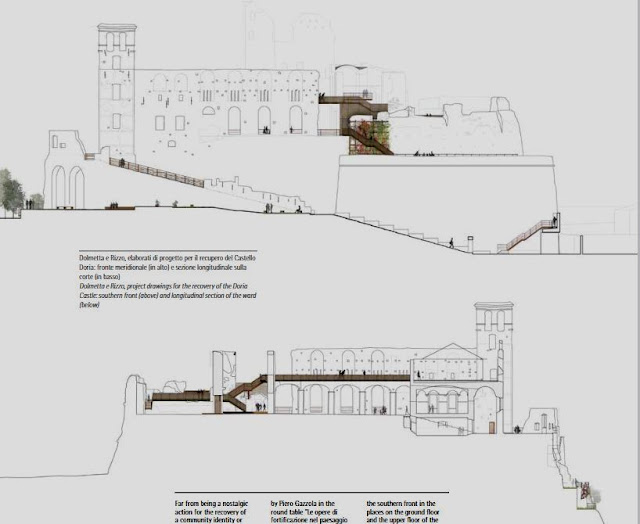

.JPG)

